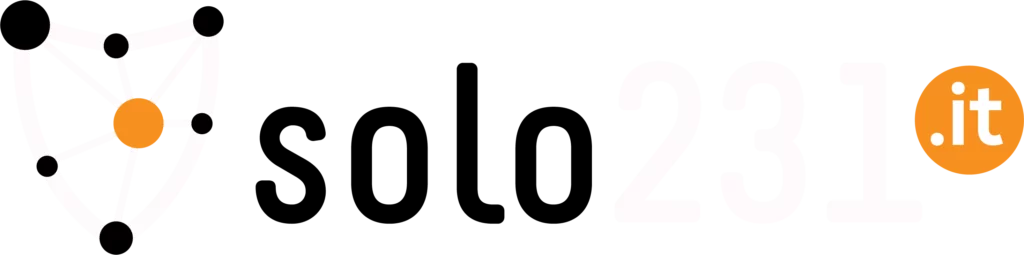Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è stato audito lo scorso 7 luglio nell’ambito del Tavolo tecnico promosso dal Ministero della Giustizia per la revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
In occasione dell’audizione, la delegazione dei commercialisti ha presentato il Documento “Riforma del D.lgs. 231/2001: osservazioni e proposte” – predisposto dall’Osservatorio Nazionale D.lgs. 231/2001 – che persegue un duplice obiettivo. Da un lato, quello di analizzare e comprendere le principali direttrici di riforma attualmente in discussione; dall’altro, formulare proposte e suggerimenti operativi, basati sull’evoluzione giurisprudenziale, sugli sviluppi della dottrina più recente e sulla prospettiva professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Lo scopo primario dell’iniziativa è contribuire al miglioramento complessivo del quadro normativo e alla sua più efficace applicazione.
Preliminarmente, è stata evidenziata la crisi della funzione premiale che, in origine, caratterizzava il D.Lgs. 231/2001, e in particolare il Modello di organizzazione, gestione e controllo, il quale si sta progressivamente trasformando in uno strumento a prevalente finalità repressiva.
Negli ultimi anni, oltre a un’estensione ampia e disorganica del catalogo dei reati presupposto, l’attenzione si è concentrata sempre più sulla repressione delle condotte illecite e sull’applicazione, spesso sproporzionata, delle misure cautelari.
Tra le principali criticità sollevate, emerge la crisi di legittimazione del “sistema 231”, aggravata da un’eccessiva discrezionalità interpretativa e dalla carenza di criteri normativi vincolanti. Ciò avviene nonostante i tentativi della giurisprudenza di sistematizzare concetti chiave, quali la colpa di organizzazione e l’idoneità del modello organizzativo.
Per quanto riguarda il catalogo dei reati presupposto, non si registra una visione univoca. Alcuni autori ritengono che l’inclusione anche di reati “non economici” risponda all’esigenza di presidiare la legalità nei luoghi di lavoro e nei processi aziendali. Altri, invece, sottolineano il rischio di una dispersione della funzione del modello 231 e di un eccessivo onere a carico delle imprese.
Tra le soluzioni proposte nel Documento in esame, vi è l’introduzione di un sistema di classificazione dei reati per livelli di rilevanza, articolato come segue:
-
- Reati strutturalmente rilevanti: reati che, per natura e diffusione, impongono un presidio generalizzato (es. corruzione, reati ambientali, reati tributari);
-
- Reati settorialmente rilevanti: reati la cui rilevanza dipende dalla specifica attività svolta dall’impresa;
-
- Reati genericamente rilevanti: reati che assumono rilievo solo laddove emerga una responsabilità organizzativa effettivamente accertata.
Anche in relazione all’ambito soggettivo di applicazione del Decreto, le opinioni risultano divergenti: da una parte, vi è chi propone l’introduzione di modelli organizzativi semplificati, elaborati con il supporto di linee guida predisposte da autorità competenti o associazioni di categoria; dall’altra, chi suggerisce l’esclusione tout court delle microimprese dall’applicazione della normativa.
Tale ultima ipotesi è stata tuttavia espressamente respinta dall’Osservatorio 231, secondo cui l’eventuale esclusione delle microimprese rischierebbe di determinare aree di irresponsabilità non giustificate all’interno del sistema.
Al contrario, una semplificazione modulata e proporzionata appare più coerente con i principi di equità e proporzionalità, garantendo al contempo l’effettività del sistema e la sostenibilità per le realtà di minori dimensioni.
Pur rappresentando uno strumento fondamentale per la prevenzione dei reati in ambito aziendale, il D. Lgs, 231/2001 non disciplina in modo specifico le dinamiche proprie dei gruppi di imprese, lasciando margini di incertezza applicativa.
L’Osservatorio esprime l’esigenza di una declinazione normativa chiara dei presupposti di responsabilità della holding, nei casi in cui il reato sia commesso nell’ambito di una società controllata appartenente al medesimo gruppo.
In tal senso, è stato richiamato e ritenuto condivisibile l’orientamento della giurisprudenza maggioritaria, che riconosce la responsabilità della capogruppo solo laddove il reato sia stato commesso:
-
- in concorso tra esponenti della controllata ed esponenti della holding, e
-
- nell’interesse o a vantaggio anche della holding.
Una tale impostazione consentirebbe di evitare il rischio di una responsabilizzazione della capogruppo fondata su criteri eccessivamente discrezionali, definiti caso per caso dalla giurisprudenza, e garantirebbe maggiore certezza del diritto.
Nel Documento si richiama, inoltre, l’importanza di promuovere una collaborazione processuale attiva, valorizzando le condotte premiali e gli strumenti riparatori, principi ampiamente condivisi e accolti dall’Osservatorio 231.
A tal proposito, l’Osservatorio sottolinea la necessità di predisporre meccanismi di verifica oggettiva delle condotte riparatorie, al fine di evitare che gli strumenti premiali si traducano in meri strumenti deflattivi del processo penale, privi di reale efficacia sul piano sostanziale.
In tale ottica, si propone l’istituzione di una procedura di validazione delle condotte collaborative da parte di un’autorità amministrativa terza, sul modello di organismi già esistenti quali ANAC, Agenzia delle Entrate, INAIL, con l’obiettivo di integrare detta validazione nel fascicolo del processo penale, rafforzandone la rilevanza e l’impatto valutativo.
Viene, inoltre, affrontato il tema del coordinamento tra giurisdizioni e del rispetto del principio del ne bis in idem.
A tal riguardo, il Consiglio Nazionale propone l’introduzione di una forma di coordinamento probatorio tra le diverse giurisdizioni, prevedendo effetti vincolanti delle pronunce definitive di assoluzione, ove intervenute.
Tale soluzione contribuirebbe a rafforzare la certezza del diritto e a limitare la duplicazione degli accertamenti, in un’ottica di maggiore coerenza e razionalizzazione del sistema sanzionatorio.
Infine, sono state formulate alcune proposte di riforma integrative del D.lgs. 231/2001, frutto di un’analisi critica del quadro normativo vigente, dell’evoluzione giurisprudenziale – sia nazionale che europea – e del patrimonio dottrinale sviluppatosi nei oltre vent’anni di applicazione della disciplina sulla responsabilità da reato degli enti.
Tra le proposte avanzate, il CNDCEC suggerisce di escludere “l’attivazione sic et simpliciter della responsabilità dell’ente per i reati presupposto, prevedendo che la stessa possa essere prevista solo per quelli puniti con pena edittale superiore – nel minimo – a due anni di reclusione”.
Tale proposta si fonda sul principio di offensività che, tanto nel diritto penale sostanziale quanto in quello processuale, impone di concentrare l’azione repressiva sui reati realmente lesivi di beni giuridici rilevanti. Di conseguenza, l’estensione dell’ambito applicativo del D.lgs. 231/2001 anche a reati bagatellari o meramente formali rischia di accrescere inutilmente il carico burocratico a carico delle imprese, senza produrre un concreto effetto di prevenzione.
La “messa alla prova” potrebbe costituire un’opportunità per l’ente di dimostrare, già in sede processuale, una concreta volontà di revisione e miglioramento delle proprie prassi organizzative, attraverso l’adozione di condotte riparatorie quali il risarcimento dei danni, la collaborazione con le autorità competenti e l’adozione di modelli idonei a prevenire futuri illeciti.
Nel Documento, viene avanzata l’idea di introdurre un meccanismo di valorizzazione della “storia aziendale” dell’ente in termini di compliance sostanziale, mediante l’attribuzione di “crediti di legalità organizzativa” attraverso indicatori oggettivi quali, ad esempio, la durata del MOG e aggiornamenti periodici, gli audit effettuati e riscontri positivi, le condotte correttive adottate, nonché gli investimenti in formazione e cultura della legalità.
Ad ultimo, si sofferma sul delicato e già ampiamente dibattuto tema della prescrizione degli illeciti degli enti rispetto a quella dei reati presupposto delle persone fisiche.
In tale contesto, una parte della dottrina – tra cui i commercialisti – propende per l’introduzione di una disciplina della prescrizione c.d. “rafforzata” che preveda, ad esempio, l’introduzione di un termine massimo di prescrizione oltre il quale l’azione non possa più essere esercitata, anche in presenza di atti interruttivi.
Un’ulteriore soluzione potrebbe essere rappresentata dallo sviluppo di istituti premiali, fondati sul rafforzamento delle procedure di patteggiamento e sulla previsione di benefici solo in caso di collaborazione tempestiva e adozione di efficaci modelli organizzativi (es. esclusione della responsabilità per chi dimostra di aver adottato e attuato modelli di prevenzione idonei oppure sanzioni ridotte e, in caso di ravvedimento operoso, esclusione da responsabilità, ma sempre entro limiti temporali certi).
Pertanto, si legge nelle conclusioni che la riforma, per essere efficace, “dovrà conciliare esigenze di efficienza economica, certezza giuridica e tutela dei valori costituzionali. Una disciplina moderna non deve limitarsi a punire gli enti, ma deve indurli a prevenire e collaborare.
Solo una riforma meditata, equilibrata e partecipata da tutti i protagonisti del sistema potrà restituire alla disciplina 231 il suo ruolo originario: non solo strumento repressivo, ma leva di governance e responsabilità sociale dell’impresa”.