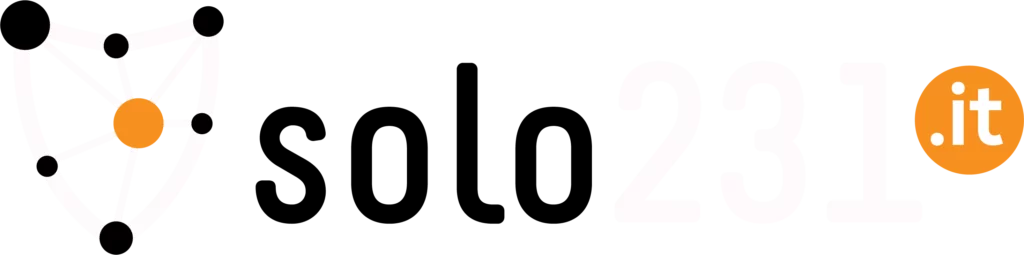Con la sentenza n. 95 del 2025, depositata il 3 luglio, la Corte Costituzionale ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate da tredici giudici di merito e dalla sesta sezione penale della Cassazione aventi ad oggetto l’art. 1, comma 1, lett. b), della Legge n. 114/2024, nella parte in cui ha abrogato l’art. 323 c.p. (reato di abuso d’ufficio).
Le censure fondate sugli artt. 3, 97, 11 e 117, primo comma, Cost., sono state tutte rigettate.
Nella parte iniziale della motivazione, la Corte riepiloga le ordinanze di rimessione, dalle quali emergono casi concreti di abuso di potere da parte di pubblici ufficiali – oggi non più penalmente rilevanti – tra cui condotte attribuite a magistrati, rettori universitari, docenti e personale amministrativo.
Uno dei temi centrali del giudizio ha riguardato il presunto contrasto tra l’abrogazione dell’abuso di ufficio e gli obblighi internazionali assunti dall’Italia con la Convenzione di Mérida, in particolare rispetto al principio di non regresso (c.d. stand still), che vieta agli Stati di smantellare strumenti essenziali di tutela penale contro la corruzione.
Le tredici ordinanze dei giudici di merito e la Corte di cassazione, pur con argomentazioni differenti, hanno espresso preoccupazione sui possibili contrasti: i primi hanno evidenziato il rischio di un abbassamento degli standard minimi di tutela contro la corruzione nell’amministrazione pubblica, mentre la Cassazione ha denunciato una compromissione sistemica dell’efficacia complessiva del sistema preventivo, minando gli obiettivi stessi della Convenzione.
Inoltre, sono state sollevate censure di irragionevolezza, per violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), evidenziando il rischio di disparità di trattamento tra condotte simili, nonché per lesione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), a causa del “vuoto di tutela” creato dalla riforma.
La Corte ha riconosciuto l’esistenza di effettivi vuoti di tutela penale derivanti dall’abrogazione dell’art. 323 c.p., ma ha ribadito che tale scelta spetta al legislatore e non può essere sindacata dal giudice costituzionale, soprattutto quando comporterebbe effetti sfavorevoli per l’imputato (in malam partem), in contrasto con il principio di legalità.
Quanto alla Convenzione di Mérida, la Consulta ha escluso che imponga il mantenimento dell’abuso d’ufficio o di specifiche incriminazioni, chiarendo che eventuali violazioni internazionali possono dar luogo a responsabilità dello Stato, ma non giustificano interventi correttivi da parte della Corte.
Pur ritenendo ammissibili le questioni sollevate ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost., la Corte ha rilevato che non vi è alcuna violazione degli obblighi internazionali. Le ulteriori censure basate sugli artt. 3 e 97 Cost., relative all’irragionevolezza dell’abrogazione e al vuoto di tutela per i principi di buon andamento e imparzialità della P.A., sono state dichiarate inammissibili in quanto inciderebbero negativamente sulla posizione dell’imputato, in violazione del divieto di interventi in malam partem.
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata (sent. n. 394/2006, n. 17/2021 e n. 8/2022), ribadendo che spetta al legislatore, e non alla Consulta, valutare l’opportunità politico-criminale di indurre, modificare o abrogare le fattispecie penali.
Nel passaggio conclusivo, si legge che:
“se gli indubbi vuoti di tutela penale che derivano dall’abolizione del reato – emblematicamente illustrati dalla vicende oggetto dei giudici a quibus – possano ritenersi o meno compensati dai benefici che il legislatore si è ripromesso di ottenere, […], è questione che investe esclusivamente la responsabilità politica del legislatore, non giustiziabile innanzi a questa Corte al metro dei parametri costituzionali e internazionali esaminati”.
La Corte rivendica il rispetto del principio di legalità e della riserva di legge in materia penale (art. 25, comma 2, Cost.) e chiarisce che eventuali violazioni di obblighi internazionali, come quelli derivanti dalla Convenzione di Mérida, possono semmai determinare responsabilità dello Stato, ma non impongono una riscrittura giudiziale delle fattispecie incriminatrici.
Tale pronuncia apre importanti riflessioni sulla responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e sollecita l’attenzione preventiva rafforzata da parte degli operatori della compliance.
L’eliminazione dell’abuso d’ufficio dal catalogo dei reati presupposto non comporta infatti una riduzione automatica dei rischi sanzionatori per gli enti, ma rende necessaria una rivalutazione qualitativa delle aree di rischio e una riclassificazione delle condotte prima inquadrate nell’ambito dell’art. 323 c.p.
In particolare, due fattispecie che assumono oggi un rilievo rafforzato nella mappatura dei rischi e nell’aggiornamento dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, sono:
- l’art. 314 bis c.p., sull’indebita destinazione di denaro o cose mobili;
- l’art. 346 bis c.p., sul traffico di influenze illecite.
Questi reati, già introdotti nella rubrica e nel corpo dell’art. 25, comma 1 del D.lgs. 231/2001, rappresentano oggi possibili “recipienti normativi” per condotte che, prima della riforma, sarebbero state attratte dal più ampio e sfumato paradigma dell’abuso d’ufficio. Ne deriva l’opportunità – e, per molti enti, la necessità – di aggiornare i modelli di organizzazione, rafforzando i presidi interni su:
– rapporti con la pubblica amministrazione;
– gestione di fondi e risorse pubbliche;
– attività di intermediazione con soggetti pubblici, anche attraverso terzi.
L’effetto della pronuncia della Consulta, che dichiara legittima l’eliminazione dell’art. 323 c.p. pur riconoscendo la presenza di “indubbi vuoti di tutela”, non deve condurre a un arretramento della vigilanza organizzativa, ma piuttosto a una riprogettazione responsabile dei protocolli 231, orientata a prevenire comportamenti che – seppur non più penalmente rilevanti ai sensi dell’abrogato art. 323 – possono comunque integrare fattispecie oggi più delimitate ma non meno gravi.
In conclusione, la sentenza n. 95/2025, pur essendo un atto “negativo” (dichiara l’inammissibilità delle questioni), produce un effetto di forte responsabilizzazione per enti pubblici e privati.
Il legislatore ha oggi il compito di valutare un nuovo assetto normativo per colmare i vuoti indicati dalla Corte. Nel frattempo, il D.lgs. 231/2001 resta lo strumento più efficace per prevenire comportamenti illeciti anche in assenza di una fattispecie incriminatrice diretta.
In questo contesto, l’efficacia del modello organizzativo diventa l’unica vera linea di difesa preventiva. L’aggiornamento periodico, l’analisi del rischio effettivo e la costruzione di una cultura etica aziendale non sono solo doveri normativi, ma leve strategiche di protezione dell’interesse dell’ente e della collettività.
La Corte ha certificato l’esistenza di una zona grigia. Tocca ora agli operatori della compliance dimostrare che prevenire è ancora possibile.