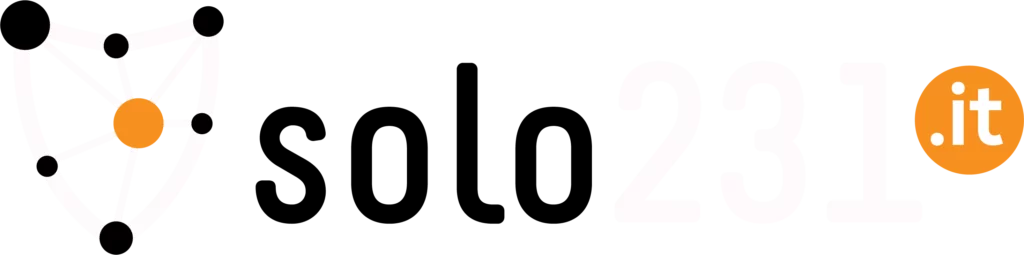La recente produzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, affiancata dalla giurisprudenza amministrativa e civile, offre un’interessante chiave di lettura sull’effettiva applicazione del D.lgs. 24/2023 in materia di whistleblowing.
In particolare, la delibera ANAC n. 380 del 30 luglio 2024 ha affrontato un caso emblematico, nel quale l’Autorità ha riconosciuto la natura ritorsiva di una riorganizzazione aziendale disposta in seguito a una segnalazione interna che denunciava l’assegnazione irregolare di incarichi dirigenziali e un conflitto d’interessi in capo al Direttore dell’ente.
Il dipendente segnalante, in conseguenza della propria denuncia, era stato trasferito in una sede priva di agibilità e di strumenti operativi adeguati, gli erano state assegnate mansioni inattuabili e aveva successivamente ricevuto una valutazione negativa della performance lavorativa. L’ANAC, rilevando la natura ritorsiva delle misure adottate, ha dichiarato la nullità del provvedimento e ha irrogato al dirigente responsabile una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro.
Ancora più articolato si presenta il contesto analizzato nella delibera n. 426 del 25 settembre 2024, in cui l’ANAC ha nuovamente riconosciuto il carattere ritorsivo di una riorganizzazione aziendale e ha dichiarato la nullità del relativo provvedimento, sanzionando il Sindaco autore della misura con una multa di 5.000 euro.
In tale circostanza, il segnalante aveva denunciato non solo un demansionamento, ma anche penalizzazioni di carattere retributivo e il sequestro – giudicato pretestuoso – del proprio computer aziendale.
Le segnalazioni riguardavano presunte irregolarità in diverse procedure di affidamento pubblico, originariamente indirizzate al Segretario Generale, anche in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), e successivamente estese ad altri organi dell’ente.
Il Segretario Generale e il Sindaco hanno improntato la propria difesa sull’assunto che le misure organizzative adottate rispondessero a legittime esigenze disciplinari e che le segnalazioni, essendo state inoltrate al di fuori dell’orario di servizio, non potessero essere considerate valide.
Tali argomentazioni sono state smentite dall’ANAC, che ha ribadito come anche una segnalazione effettuata durante un periodo di malattia sia da considerare valida, a condizione che riguardi fatti appresi in ragione del proprio ruolo lavorativo e connessi a un interesse pubblico.
L’Autorità ha inoltre chiarito che la rottura del rapporto fiduciario, frequentemente invocata per giustificare modifiche organizzative, non può di per sé legittimare la revoca di incarichi in assenza di motivazioni oggettive, coerenti e trasparenti.
Diversamente, la natura ritorsiva del sequestro del computer aziendale è stata esclusa, poiché ritenuto giustificato da problematiche tecniche documentate e non sintomatico di una finalità persecutoria. Proprio questa valutazione complessiva ha condotto a una sanzione di minore entità rispetto a quella prevista nella delibera n. 380, pari a 5.000 euro contro i precedenti 10.000.
Una circostanza, quest’ultima, che solleva interrogativi sull’effettiva efficacia deterrente delle sanzioni previste: il timore, infatti, è che importi troppo contenuti possano essere percepiti dai responsabili come un costo sopportabile, anziché come un autentico disincentivo a condotte ritorsive, finendo per vanificare, almeno in parte, le finalità protettive della Direttiva (UE) 2019/1937.
Di diverso tenore si presenta la delibera n. 463 del 16 ottobre 2024, con la quale è stato archiviato un procedimento sanzionatorio a carico dell’Amministratore Delegato di una società. La segnalazione proveniente dal whistleblower lamentava, tra le altre cose, rimproveri verbali, la revoca di incarichi, limitazioni all’accesso e infine il licenziamento per giusta causa, ritenute ritorsioni successive a precedenti denunce di presunti illeciti.
In una prima fase, l’ANAC aveva ritenuto indicativa di una possibile ritorsione la coincidenza temporale tra la segnalazione e il licenziamento. Tuttavia, la documentazione dettagliata fornita dalla società ha consentito di ricostruire l’iter disciplinare, avviato indipendentemente dalla denuncia e basato su presupposti autonomi e legittimi. In assenza di elementi concreti per configurare un intento ritorsivo, l’Autorità ha quindi disposto l’archiviazione del procedimento.
Ben diverso l’esito della delibera n. 587 del 16 dicembre 2024, che ha riguardato la condotta della Dirigente Scolastica di un istituto nei confronti di un dipendente autore di una segnalazione interna relativa a irregolarità contabili e amministrative. Dopo la segnalazione, il whistleblower è stato sottoposto a un procedimento disciplinare per un’assenza ingiustificata, sanzionato con la sospensione dal servizio e, soprattutto, escluso dall’incarico di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), assegnato ad altro personale.
La Dirigente ha giustificato la propria decisione con riferimento a una graduatoria interna risalente all’anno scolastico precedente. L’ANAC ha tuttavia ritenuto tale graduatoria non conforme alla normativa vigente e utilizzata in modo pretestuoso, con l’evidente intento di escludere il segnalante. Ha pertanto accertato la natura ritorsiva della condotta e irrogato una sanzione di 5.000 euro.
Importanti spunti di riflessioni si traggono anche dalla giurisprudenza amministrativa e civile.
Con sentenza n. 18053 del 18 ottobre 2024, il TAR Lazio ha respinto il ricorso di un whistleblower contro l’archiviazione, da parte dell’ANAC, di due procedimenti sanzionatori nei confronti del RPCT di un Consorzio di Bonifica, accusato di aver adottato misure discriminatorie. Secondo la ricostruzione del Tribunale, il trasferimento del segnalante presso una diversa sede era stato deciso nell’ambito di una riorganizzazione dettata dalla necessità di rafforzare la presenza territoriale dell’ente, a fronte della riduzione dell’organico.
Non essendo emerso alcun nesso causale diretto tra la segnalazione e il trasferimento, il TAR ha confermato la legittimità dell’archiviazione disposta dall’ANAC, rigettando il ricorso.
Sul fronte della Corte di Cassazione si registrano due interventi di particolare rilievo. Con la sentenza n. 17715 del 27 giugno 2024, la Suprema Corte ha confermato il licenziamento per giusta causa di una dirigente che aveva utilizzato strumentalmente il whistleblowing per finalità di conflitto personale, diffondendo accuse infondate e diffamatorie nei confronti del proprio superiore.
La dirigente, già destinataria di precedenti sanzioni disciplinari, aveva pubblicato su Facebook stralci di conversazioni manipolate in modo da screditare il superiore gerarchico.
La Suprema Corte ha affermato con chiarezza che tale condotta non poteva essere qualificata come una legittima segnalazione ai sensi della normativa in materia di whistleblowing, in quanto l’intento diffamatorio era evidente e mirava a perseguire interessi esclusivamente personali, in contrasto con l’impianto normativo che tutela l’interesse pubblico.
Un ulteriore contributo è giunto con l’ordinanza n. 33452 del 19 dicembre 2024, in cui la Cassazione ha affrontato il delicato bilanciamento tra l’obbligo di fedeltà del lavoratore e il diritto di denuncia.
La Corte ha chiarito che il lavoratore non viola l’art. 2105 del codice civile, in materia di obbligo di fedeltà, quando segnala fatti illeciti che ritiene siano stati commessi all’interno dell’azienda. Al contrario, un’interpretazione opposta comporterebbe il rischio di legittimare, anche solo implicitamente, una sorta di “dovere di omertà”.
Inoltre, è stato precisato che la denuncia di fatti potenzialmente rilevanti sotto il profilo penale non può di per sé costituire giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, a meno che non emerga un intento calunnioso da parte del lavoratore, cioè la consapevolezza della non veridicità dei fatti segnalati e la volontà di accusare ingiustamente il datore di lavoro. Fondamentale, in questo senso, è anche che il lavoratore si astenga dal dare pubblica diffusione alle notizie fornite alle autorità competenti.
Resta tuttavia aperto il tema cruciale dell’effettiva efficacia dissuasiva delle sanzioni previste, che in taluni casi appaiono ancora troppo modeste rispetto alla gravità delle condotte sanzionate, rischiando così di compromettere gli obiettivi di tutela e prevenzione alla base della disciplina sul whistleblowing.