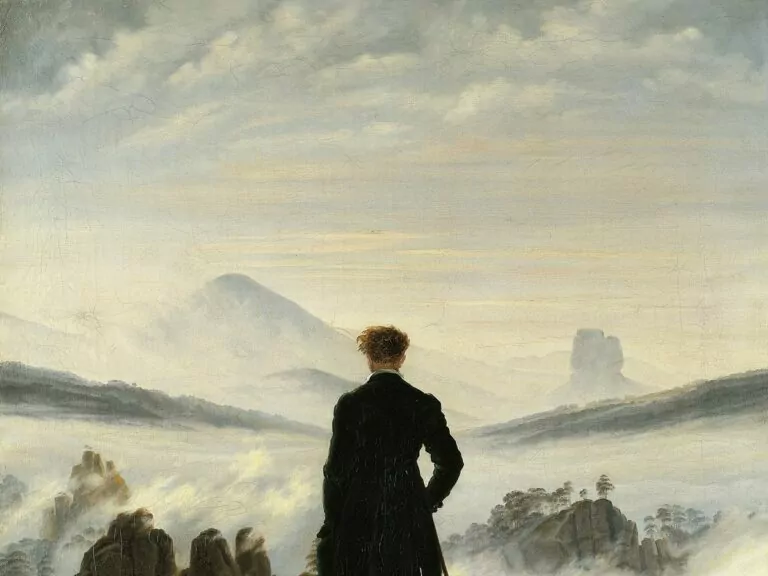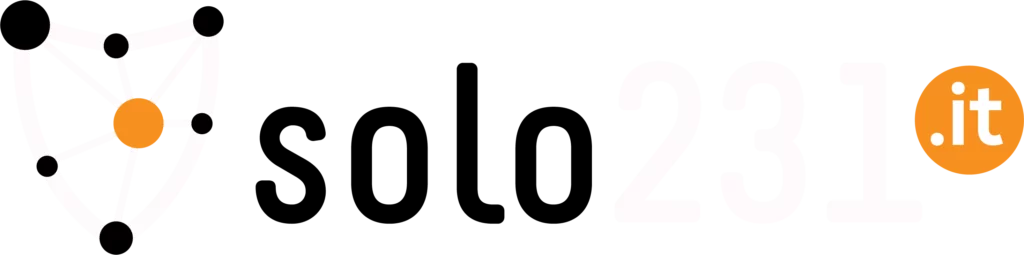La rilevante entità del profitto tratto dal reato, richiesta dall’art.13 d.lgs. 231/2001 quale condizione per l’applicazione delle sanzioni interdittive all’Ente, può essere legittimamente dedotta, oltre che dal dato oggettivo della consistenza del vantaggio conseguito (es. una consistenza autoevidente, che può di per sé assumere decisiva valenza), anche dal dato soggettivo, cioè in ragione delle caratteristiche dell’ente, dell’impatto, della incidenza del profitto illecito – e, quindi, dell’arricchimento indebito – rispetto alla specifica attività dell’ente, al suo volume di affari, alla struttura dell’impresa, alla sua posizione sul mercato.
Pertanto, «un profitto può essere non oggettivamente, in assoluto, quantitativamente rilevante ma può diventarlo rispetto alla struttura dell’ente nei cui confronti si procede».
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23329/2025, con la quale è stata annullata senza rinvio la pronuncia impugnata dalla società ricorrente, limitatamente all’applicazione delle sanzioni interdittive.
Preliminarmente, anche al fine di comprendere appieno il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, è opportuno riepilogare brevemente i fatti oggetto della vicenda.
La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui sono stati condannati l’imputata per il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. e la società di cui la stessa era rappresentante legale, per l’illecito previsto dall’art. 24 D.Lgs. 8 giugno 2001, n 231.
In particolare, alla predetta era stato contestato, in concorso con altro soggetto poi assolto, di aver indebitamente percepito, mediante dichiarazioni attestanti fatti non rispondenti al vero, contributi agevolati erogati in favore della società dal Gestore dei Servizi Energetici.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione l’imputata e la società che, nei motivi di gravame, ha lamentato il vizio della sentenza impugnata in relazione all’applicazione della sanzione interdittiva, nonostante l’assenza di un profitto di rilevante entità.
L’art. 13 del D.lgs. 231/2001 subordina l’irrogazione della sanzione interdittiva, ove espressamente prevista, all’alternativa ricorrenza o di un profitto di rilevante entità ovvero della reiterazione degli illeciti; ipotesi, quest’ultima, che, ai sensi del successivo articolo 20, si configura solo quando l’ente, già condannato in via definitiva – almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commetta un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.
Per quanto concerne il concetto di “profitto di rilevante entità”, il legislatore non ha fornito una definizione normativa, né esiste, ad oggi, una nozione generale di “profitto”. Sul punto si è, quindi, pronunciata la giurisprudenza, la quale ha più volte chiarito che il profitto cui fa riferimento l’art.13 d.lgs. 231/2001, a differenza del profitto inteso come vantaggio materiale direttamente derivante dal reato, deve essere inteso “in senso dinamico”.
Ciò implica la possibilità di ricomprendere anche quei vantaggi economici non direttamente, né immediatamente conseguiti attraverso la commissione dell’illecito, ma comunque ad esso riconducibili.
Nella nozione di profitto di rilevante entità rientrano i vantaggi economici relativi alla posizione di privilegio che l’ente collettivo può acquistare sul mercato.
Possono assumere rilievo:
- a) gli ulteriori lavori acquisiti dall’impresa a seguito di una pregressa aggiudicazione illecita;
- b) l’assunzione dei requisiti per la partecipazione a gare di affidamento di lavori pubblici;
- c) l’incremento del merito dell’impresa presso gli istituti bancari o finanziari;
- d) l’aumento del potere contrattuale nei confronti dei fornitori e subappaltatori.
Questa stessa tendenza ha condotto il legislatore ad ampliare, con riferimento a specifiche fattispecie di reato, l’oggetto della confisca (si pensi, ad esempio, all’art. 416-bis, settimo comma, c.p.). Difatti, rientrano fra i beni confiscabili, oltre al prodotto, al profitto e al prezzo del reato, anche le cose “che ne costituiscono l’impiego”.
In tal modo, si è resa possibile l’ablazione non solo dei proventi direttamente derivanti dalla commissione del reato, ma anche delle utilità economiche nelle quali tali proventi siano stati trasformati o reinvestiti.
La Suprema Corte ha, dunque, evidenziato come tale orientamento imponga una riflessione che sposti l’attenzione, ai fini della definizione di profitto di rilevante entità, non tanto sul profilo della derivazione indiretta del vantaggio, quanto piuttosto su quello quantitativo.
In tale prospettiva, ciò che assume rilievo è la “rilevanza della consistenza del vantaggio conseguito dall’illecito”, comprendendovi ogni utilità comunque derivante dal reato, anche indiretta, e, quindi, anche quei vantaggi tradizionalmente qualificati come “dinamici”.
«L’ampliamento della nozione di profitto derivante dall’illecito, attraverso il riconoscimento della rilevanza anche dei vantaggi indiretti, conduce, cioè, a conformare diversamente la nozione di profitto di cui all’art. 13 e ad attribuire ad essa una nozione per certi versi più ristretta, perché non più configurabile nei casi in cui l’accrescimento, pur comprendendo vantaggi “ulteriori” rispetto a quello immediatamente conseguito dal reato, non sia comunque quantitativamente rilevante».
La Cassazione ha, pertanto, ritenuto la sentenza carente sotto il profilo motivazionale, rilevando come la Corte d’appello si sia limitata a un riferimento meramente incidentale al profitto “rilevantissimo” conseguito, senza tuttavia fornire un’adeguata argomentazione.